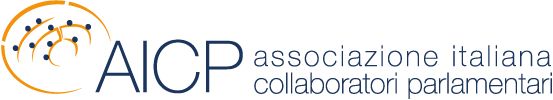Il ruolo del Parlamento nel Rapporto sulla legislazione 2024 - 2025
Articolo pubblicato da Parlamento Magazine numero 06 del luglio 2025 nell'ambito di una collaborazione con AICP
Lo scorso 14 aprile 2025, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, è stato presentato il consueto Rapporto sulla legislazione, relativo agli anni 2024 e 2025, elaborato dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati ed incentrato, tra l’altro, sul ruolo del Parlamento nel sistema multilivello e sul potere normativo del Governo.
Il rapporto rileva che, nella legislatura in corso, alla data del 13 febbraio 2025, su un totale di 181 leggi approvate 71 sono leggi di conversione di decreti-legge (pari complessivamente al 39,2%), mentre nel corrispondente periodo della 18a legislatura il dato era di 48 su 138 (pari al 34,8%). In termini di numero di parole, i decreti-legge convertiti occupano il 60,7% del totale, in diminuzione rispetto al 68,4% della scorsa legislatura, caratterizzata però dall’emergenza pandemica e dell’adozione di decreti-legge di ponderose dimensioni: si pensi, ad esempio, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, composto da 127 articoli che diventano addirittura 171 dopo la conversione, o al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, composto da 266 articoli che dopo la conversione salgono a 341.
Quanto alla delega legislativa, il rapporto rileva che nella 19a legislatura sono state approvate 12 leggi contenenti disposizioni di delega al Governo, con una tendenza in aumento rispetto al corrispondente periodo della precedente legislatura durante il quale le leggi delega erano solo 7. Del pari, nel corso dell’attuale legislatura sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 101 decreti legislativi delegati, 58 dei quali in attuazione di direttive dell’Unione europea, a fronte di 79 decreti legislativi pubblicati nel corrispondente periodo della 18a legislatura (51 quelli emanati in attuazione di norme europee).
Il decreto-legge, dunque, si caratterizza sempre più come principale strumento di legislazione, nel quadro di una tendenza che ha preso piede ormai da tempo e che denota una radicale trasformazione del ruolo del Parlamento. Per un verso, infatti, il Governo si conferma essere il vero dominus della legislazione, non solo in quanto soggetto privilegiato nella fase dell’iniziativa – nella legislatura in corso, ad esempio, sono state approvate 71 leggi di conversione di decreti-legge e 62 leggi ordinarie di iniziativa governativa su un totale di 180 leggi ordinarie complessivamente approvate (con una percentuale pari al 73,9%), in lieve diminuzione rispetto al corrispondente periodo della 18a legislatura il cui dato è di 48 leggi di conversione e 56 leggi ordinarie di iniziativa governativa su un totale di 137 leggi ordinarie (75,9%) – ma anche per i forti poteri di impulso e direzione nell’ambito della fase di approvazione delle leggi, poteri che vengono esercitati mediante vari strumenti, tra cui gli emendamenti di iniziativa governativa e, in particolare, i maxi-emendamenti (sull’approvazione dei quali viene sovente apposta la questione di fiducia). Ma si consideri altresì la prassi, ormai fortemente radicata, di concentrare la fase nevralgica dell’iter legis nella prima Camera, lasciando alla seconda il mero compito di approvare in via definitiva il provvedimento senza apportarvi modificazioni (cd. monocameralismo “alternato”), prassi che consente di snellire la fase istruttoria e che denota un’altra significativa evoluzione del ruolo delle Camere nel procedimento legislativo.
Come ha evidenziato in un recente saggio il costituzionalista Massimo Luciani, non ci si deve stupire oltremodo del protagonismo dell’esecutivo nell’esercizio della funzione legislativa, dal momento che in una forma di governo parlamentare il principale organo di indirizzo politico è, per l’appunto, il Governo e che la legge è l’atto politico per eccellenza. L’esperienza dei principali ordinamenti costituzionali europei e mondiali ne dà conferma. Ad ogni modo, il tema ha suscitato l’interesse dei Comitati per la legislazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che hanno avviato un’indagine conoscitiva congiunta sui “Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione”, a conclusione della quale è stato elaborato un documento ricco di spunti interessanti e di proposte. In particolare, i Comitati segnalano da un lato la necessità di contenere il ricorso alla decretazione d’urgenza, dall’altro l’esigenza di aggiornare le regole per la redazione degli atti normativi, contenute nelle circolari elaborate nel 2001, e di investire sulla conoscenza al fine di supportare maggiormente il legislatore nella fase istruttoria dell’iter legis, sulla base del presupposto per cui – si cita testualmente dal documento – «un Parlamento che non conosce ciò su cui è chiamato a decidere è, per forza di cose, un Parlamento più debole e meno incisivo nel circuito dell’indirizzo politico».
Che ruolo potrà dunque ritagliarsi il Parlamento nello scenario che si va delineando? Da un lato, le nuove norme in tema di partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea esaltano non poco la funzione di coordinamento svolta dalle Camere nel quadro di un ordinamento multilivello e di questo nuovo approccio si ha conferma nell’incremento del numero di proposte di Atti europei esaminati in sede di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Dall’altro, sembra esserci ormai piena consapevolezza dell’esigenza di rafforzare le Camere nell’esercizio della funzione legislativa, nonché della necessità di porre maggiore attenzione al tema della qualità degli atti normativi anche attraverso un arricchimento degli strumenti messi a disposizione delle assemblee rappresentative, in modo da ridurre il gap informativo che intercorre tra Governo e Parlamento.
di Alessandro Gigliotti
Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, membro del Direttivo di AICP